XXVIII STAGIONE 2024-2025
Domenica 27 aprile 2025, ore 17
Istituto Liszt, via A. Righi, 30
Leonardo Zunica, pianoforte
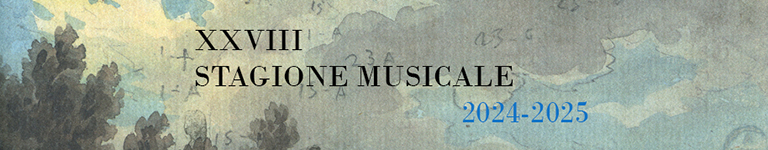
PROGRAMMA
FRANZ LISZT (1811 – 1886)
Angelus! Prière aux anges gardiens – Andante pietoso (mi maggiore)
Les cypresses à la Villa d’Este I
Les cypresses à la Villa d’Este II
Jeux d’eau à la Villa d’Este
(da Année de pelèrinage, III)
CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
Reflets dans l’eau (da Images, Livre 1, L. 110, N. 1)
MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Ondine – Lent (da Gaspard de la nuit)
LUCIANO BERIO (1925 – 2003)
Wasserklavier, 1965 (da Six Encores)
1925 – Roma, 27 maggio 2003) Wasserklavier, 1965 (da Six Encores)
FRANZ LISZT
Meeresstille, (da 12 Lieder di Schubert trascritti per il pianoforte, S.558)
HUGUES DUFOURT (1943 – )
Meerestille
Ormai è noto di quanto la figura di Franz Liszt sia stata rivalutata nel suo ruolo rivoluzionario in termini di linguaggio e immaginazione musicale. Oggi, la produzione dell’ultimo Liszt è considerata infatti anticipatrice delle conquiste musicali che matureranno all’inizio del XX secolo con Debussy, Ravel e Schõnberg e che, di risonanza in risonanza, promanano fino a certa musica del XXI secolo.
Il programma di questa serata, che si è voluto intitolare “Catene di Risonanze”, vuole infatti proporre un libero percorso di associazioni che dal terzo quaderno degli Années de Pèlerinage, ultima grande raccolta pianistica di Liszt, porta fino al lavoro di un compositore (e filosofo) di rilevanza storica come Hugues Dufourt, nato in Francia nel 1943. Questo itinerario musicale inizia dunque da Liszt, che secondo Charles Rosen fu tra i primi a porre sistematicamente al centro della propria creazione musicale pianistica il suono, inteso come entità acustica indipendente, emancipata dai procedimenti formali del classicismo. E si conclude con una composizione di Dufourt, che proprio sul suono ha focalizzato la sua ricerca compositiva.
Il 1877 vede il grande compositore ungherese sofferente, oltre che dei vari acciacchi dell’età, anche di una profonda crisi depressiva: “La mia difficoltà a scrivere aumenta e diventa eccessiva, così come la mia stanchezza di vivere! Senza compatirmi, soffro spesso di [semplicemente] esistere: la salute fisica rimane, quella dello spirito manca! Tristis est anima mea”.
Tuttavia in quell’anno vedono la luce due dei pezzi più interessanti della sua vecchiaia, che verranno pubblicati nel 1883 nel terzo quaderno Années de Pèlerinage: le Trenodie (canti funebri) Aux cyprès de la Villa d’Este I e II. Liszt stesso ne racconta la gestazione: “Ho appena scritto un centinaio di battute per pianoforte. È un’elegia piuttosto cupa e sconsolata; illuminata verso la fine da un raggio di paziente rassegnazione. Se la pubblicherò, il titolo sarà Ai cipressi della Villa d’Este”. Poco dopo aggiungerà: “Alcune foglie in più sono state aggiunte ai cipressi, non meno noiose e ridondanti delle precedenti! A dire il vero, avverto in me una terribile mancanza di talento rispetto a ciò che vorrei esprimere; gli appunti che scrivo sono pietosi. Uno strano senso dell’infinito mi rende impersonale e poco comunicativo.“
Emblematico di questa raccolta è il brano Jeux d’eau à la Villa d’Este, in cui l’elemento descrittivo del movimento, delle luminescenze e dello sciabordio delle famose fontane della villa romana presso la quale Liszt aveva a più riprese soggiornato, si trasforma una sorta di meditazione metafisica, con la citazione, posta nella partitura, del verso del Vangelo secondo Giovanni. “Sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam”.
Il concerto prosegue con due brani acquatici celeberrimi: Reflets dans l’eau composta da Claude Debussy nel 1905 (ricordiamo che il giovane compositore francese aveva potuto incontrare Liszt nel 1886, durante il suo soggiorno a Roma, come vincitore del Prix De Rome), primo numero tratto dalle Image; e Ondine di Maurice Ravel, il primo brano del trittico Gaspard de la Nuit, ispirato all’omonima opera poetica di Aloysius Bertrand (poeta francese, che fu altamente considerato da Claude Baudelaire) e composto nel 1908.
Se il brano di Debussy è uno spettacolare tentativo di rendere musicalmente il rifrangersi della luce su uno specchio d’acqua, il brano di Ravel trae spunto dall’atmosfera fluida suggerita dalla poesia di Bertrand:
Ascolta, ascolta! Son io, l’Ondina
che accarezza con le sue gocce
le lastre sonore della
tua finestra illuminata dai lividi raggi di luna;
ed ecco in abito nero sul balcone la signora del castello che
contempla la magnifica notte stellata, e il bel lago addormentato.
Ogni flutto è un’ondina che nuota nella corrente e ogni corrente un sentiero che serpeggia verso il mio
palazzo e il mio palazzo è fluido, in fondo al lago,
nel triangolo di fuoco, di terra e di aria.
Meerestille è un brano per pianoforte composto nel 1997 da Hugues Dufourt, tra i fondatori, nel 1972 con il gruppo L’Itinéraire, del cosiddetto “spettralismo”.
Lo spettralismo, corrente musicale sviluppatasi grazie al progresso tecnologico e informatico che dagli anni ’50 ha consentito di “fotografare” in maniera precisa le componenti fisico-acustiche del suono, si caratterizza in parte come reazione estetica alle logiche combinatorie che avevano animato la musica delle neo-avanguardie strutturaliste, ponendo al centro della creazione musicale il suono, declinato nelle sue articolazioni di timbro e durata.
Meerestille (Calma di mare) si può considerare come un ininterrotto processo sonoro della durata di circa 17 minuti che trae spunto dalla poesia omonima di J.W. Goethe – che ispirò tra i molti, Beethoven, Schubert (con un Lied poi trascritto per pianoforte solo da Liszt), Mendelssohn e Wolf – e la cui cellula ritmica germinale è tratta da il preludio Des pas sur la neige (Passi sulla neve) di Debussy.
Profondo silenzio tiene le acque,
posa il mare senza un’onda,
e il navigante vede inquieto
tutto il liscio che lo circonda.
Da nessuna parte un alito.
Quiete di morte che spaventa.
Nello spazio smisurato
non si muove nemmeno un’onda.
(Goethe, Meerestille)
Nella sua introduzione al brano Dufourt richiama, oltre l’atmosfera che lambisce l’oscurità e la morte, anche paesaggi di infinita attesa, come quello evocato dal romanzo il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Non ci pare azzardato considerare questa immagine come metafora di un compositore che si affaccia alle soglie del XXI secolo e che, come dice ancora Dufourt, “esplora simultaneamente passato, presente e futuro”, così come fece poco più di cento anni prima, Franz Liszt.
(Leonardo Zunica)
Leonardo Zunica. Ospite in festival nazionali e internazionali come solista e musicista da camera, Leonardo Zunica si è esibito i Italia, Francia, Spagna, Scozia, Finlandia, Ucraina, Croazia, Svizzera, Grecia, Russia. Interessato alla musica contemporanea ha curato le prime esecuzioni solistiche e da camera di Luigi Manfrin, Gabrio Taglietti, Eero Hämmeeniemi, Evgen Stankovich, Corrado Rojac e giovani compositori italiani. Il suo repertorio concertistico comprende opere complete per pianoforte a quattro mani di Mozart e Debussy (comprese le trascrizioni originali), la musica da camera di Olivier Messiaen e progetti monografici con musiche di Beethoven, Schubert, Brahms, Debussy, Satie, Szymanowsky, Gershwin, Piazzolla, Crumb. La sua attività comprende collaborazioni con i violinisti Oleksandr Semchuk e Paolo Ghidoni, i clarinettisti Anton Dressler e Gabriele Mirabassi, la pianista Maria Ala-Hannula (Ebony piano duo), il violoncellista David Cohen, il sassofonista Federico Mondelci, il musicologi Sandro Cappelletto, Guido Barbieri, e con Ivano Fossati e l’attrice Iaia Forte.
Tra le sue collaborazioni si annoverano quelle con ensembles di musica contemporanea quali Gruppo Musica Insieme (Cremona), Dedalo Ensemble (Brescia), Icarus ensemble (Reggio Emilia), Sentieri Selvaggi e, come solista, con orchestre quali l’Orchestra dell’Arena di Verona, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Nazionale Orchestra dell’Ucraina. Ha inciso per Da Vinci il Concert op. 21 di E. Chausson e il primo libro dei Prèludes di C. Debussy con la trascrizione del Prélude a l’Après-midi d’une faune di L. Borwick e per Stradivarius un concept album dedicato alla figura di Dante Alighieri. E’ stato ospite presso programmi radio televisivi su Rai Radio 3 e Rai 1.
Nella sua introduzione al brano Dufourt richiama, oltre l’atmosfera che lambisce l’oscurità e la morte, anche paesaggi di infinita attesa, come quello evocato dal romanzo il Deserto dei Tartari di Buzzati. Non ci pare azzardato considerare questa immagine come metafora di un compositore che si affaccia alle soglie del XXI secolo e che, come dice ancora Dufourt, “esplora simultaneamente passato, presente e futuro”, così come fece poco più cento anni prima, Franz Liszt.
